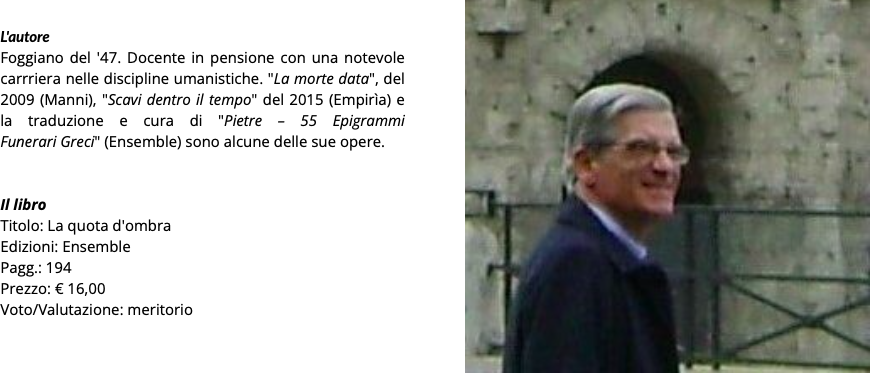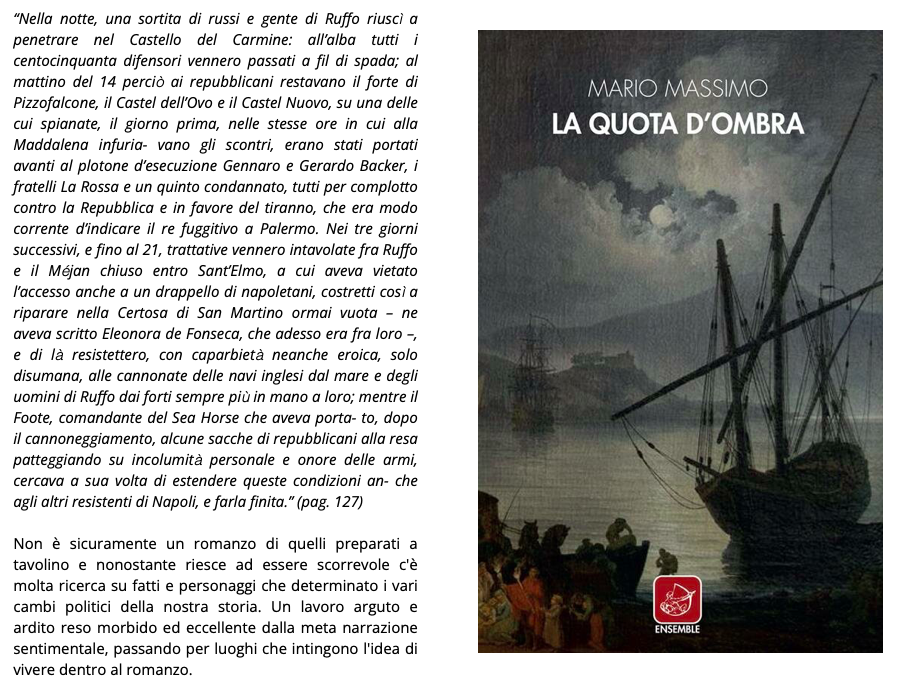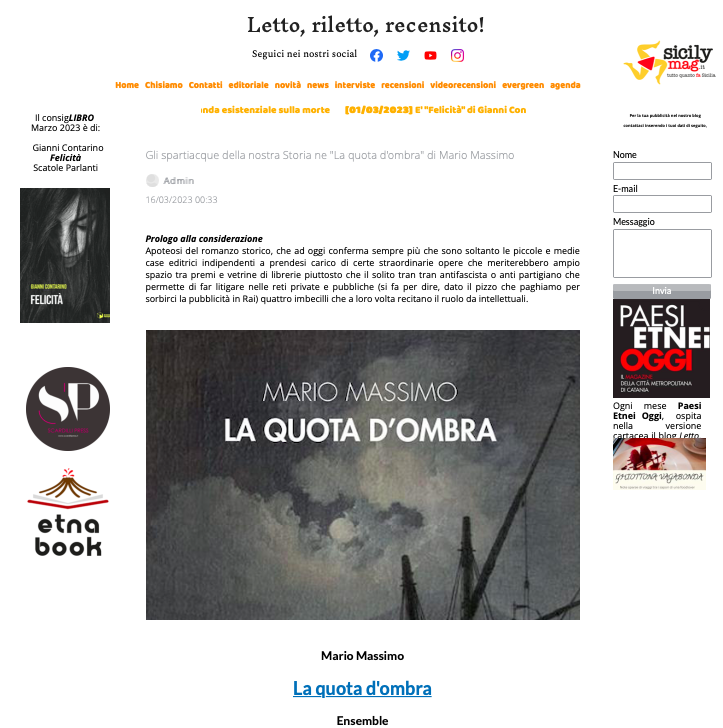
Da Letto, riletto, recensito! del 16 marzo 2023
Gli spartiacque della nostra Storia ne “La quota d’ombra” di Mario Massimo
Prologo alla considerazione
Apoteosi del romanzo storico, che ad oggi conferma sempre più che sono soltanto le piccole e medie case editrici indipendenti a prendesi carico di certe straordinarie opere che meriterebbero ampio spazio tra premi e vetrine di librerie piuttosto che il solito tran tran antifascista o anti partigiano che permette di far litigare nelle reti private e pubbliche (si fa per dire, dato il pizzo che paghiamo per sorbirci la pubblicità in Rai) quattro imbecilli che a loro volta recitano il ruolo da intellettuali.
“La quota d’ombra” (Ensemble, pp. 194, € 16,00) di Mario Massimo è uno di quegl’ottimi libri che ripercorrono vissuti storici e fasi che hanno trasformato l’andamento, per dirla in termini semplici, della società e della Storia del nostro Paese e che ha lasciato un imprintig su scala planetaria, ma nella bellezza e nella per nulla scontata narrazione da sceneggiata, l’autore riesce a portare in auge anche un intreccio sentimentale (parallelo a qui matrimoni combinati tra aristocratici delle famose Repubbliche e Ducati vari che nel 1861 spariranno a favoe dell’Unità d’Italia), che anche in questo caso non lascia traccia di allineamenti col resto di altra letteratura (piuttosto ALTA! E ce n’è poca e “La quota d’ombra” vi rientra sicuramente), tra due personaggi che daranno luce e interpretazione alla quota d’ombra di uno dei due che coinvolgerà non soltanto l’altro. Ma cosa è questa condizione che porta anche il titolo del romanzo? Certo non vi racconteremo né sveleremo, ma alcuni aspetti di contorno e alcuni flashback di triplo ritorno, vista anche l’epoca storica, ve li consegniamo. Una descrizione minuziosa delle città e dei luoghi, la paesaggistica pittorica riportata in parole: è molto dettagliato il supporto che Massimo fa anche dei ciottoli delle strade, tanto da far vivere l’esperienza dei rumori che un passo può emettere mentre corre, passeggia o si sofferma. Altra descrizione che ci ha molto convinto è la bellezza e la schiettezza nel raccontare come bella può essere una città, Foggia, dove vive Irma, che però tra attualità del tempo e prossima evoluzione, tentenna a mantenere il suo stato di grazia. Bellezza della lingua: il romanzo si dimena anche in uno stile che introduce fonemi e termini meticci e dialettiali che fanno riferimento ai tempi, ai luoghi e anche ad altre opere (sapete cos’è ad esempio il Bibelots? Nessun problema, l’autore lo spiega), ma l’onestà intellettuale di chi lo ha scritto e di chi lo ha pubblicato ne fa riferimento con alcune note, senza far perdere il genere narrativo. Altro aspetto è la poetica e la musicalità che in più parti della storia narrata viene esposta: